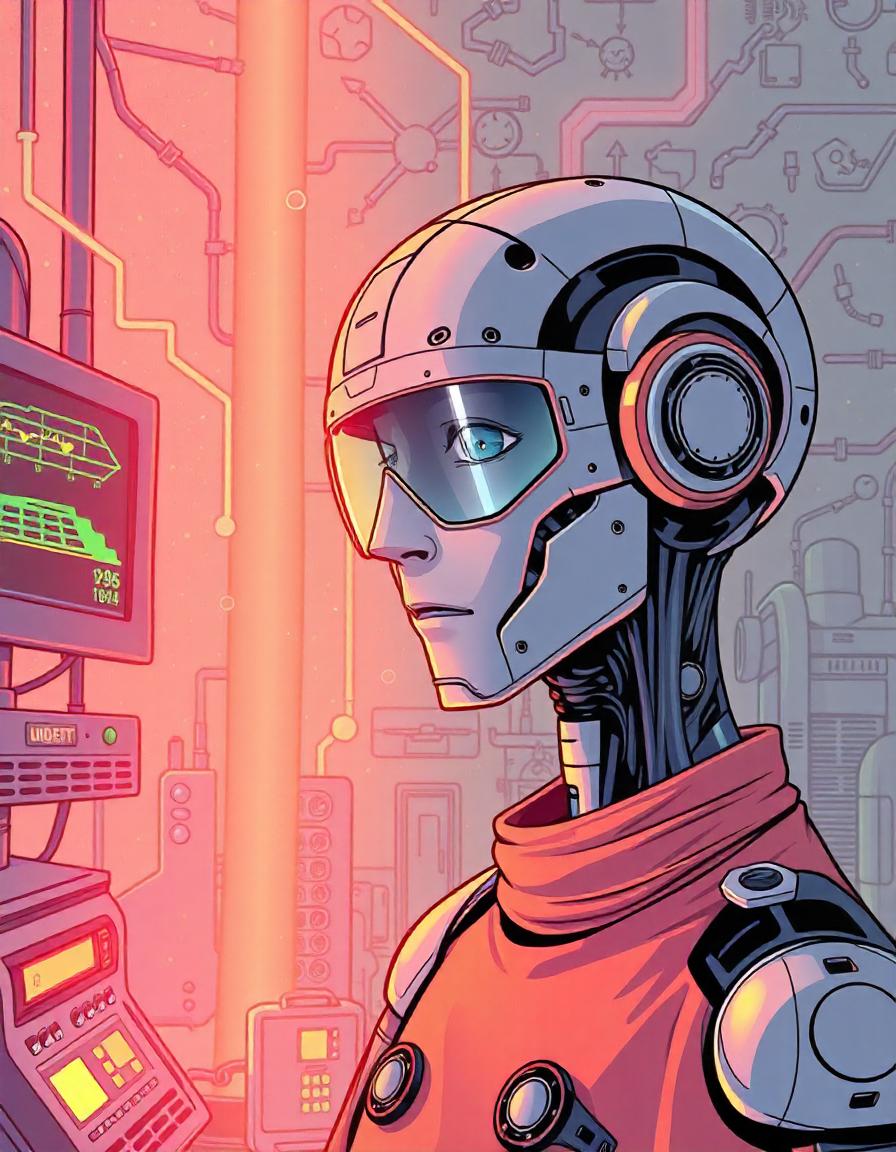Sull’Internazionale 1579, 6-12 settembre 2024, è stato pubblicato in italiano un bellissimo articolo che Morozov ha scritto per il Financial Times. Siamo nel 1968, quando parlare di informatica non significava riferirsi a un mondo che comprendeva le partite di Champions League o la tracklist di Spotify, ma piuttosto alla Guerra Fredda. Negli Stati Uniti, un agente della CIA aveva dato vita alla Control Data Corporation, un’associazione a cui aderirono diverse personalità di spicco: uomini d’affari ma anche spie. Durante una convention salirono sul palco due uomini, Avery Johnson e Warren Brodey, che iniziarono a contrastare le idee appena espresse su un roseo futuro in cui la cibernetica avrebbe servito l’umanità in ogni aspetto sociale, dalla salute alla vita sentimentale.
I due si opposero a questa visione, in cui i computer sarebbero stati al servizio dell’umanità, aprendo invece la strada a scenari più ampi e romantici, dove le macchine avrebbero esplorato nuovi confini e creato nuove opportunità.
Semplificando al massimo il concetto: secondo la filosofia della Control Data Corporation, i computer dovrebbero scansionare la nostra libreria musicale e proporci brani conformi ai nostri gusti. Secondo Johnson e Brodey, invece, l’informatica dovrebbe ampliare i nostri orizzonti e consigliarci generi che non abbiamo mai preso minimamente in considerazione. Non finalizzare, ma piuttosto divagare, ampliare, esplorare.
I due fondarono un laboratorio clandestino a Boston, l’Environmental Ecology Lab, dove “antiambienti” come stanze riempite di sacchi di cellophane o con la metà posteriore di un’automobile servivano per sviluppare una comprensione più profonda tra gli esseri umani e l’ambiente. Per “ecology” intendevano l’ecologia del pensiero, ossia l’interconnessione tra i sistemi viventi. Da qui nasceva il bisogno di spazi, e per Brodey, in particolare, lo spazio ideale era l’aula, dove si accendevano nuovi desideri.
Come siano andate le cose, lo sappiamo bene. Oggi, più che aule, i nostri desideri sono veicolati da un oggetto tascabile, presentato come l’umanizzazione dei personal computer. Ma non stiamo rendendo le macchine più umane, bensì le persone più meccaniche. L’esperimento del laboratorio fallì, principalmente per questioni economiche; del resto, Morozov conclude che “se vogliamo una tecnologia che allarghi le nostre scelte, dobbiamo ammettere che qualcuno deve finanziarla, proprio come l’istruzione pubblica, le arti e la cultura”.